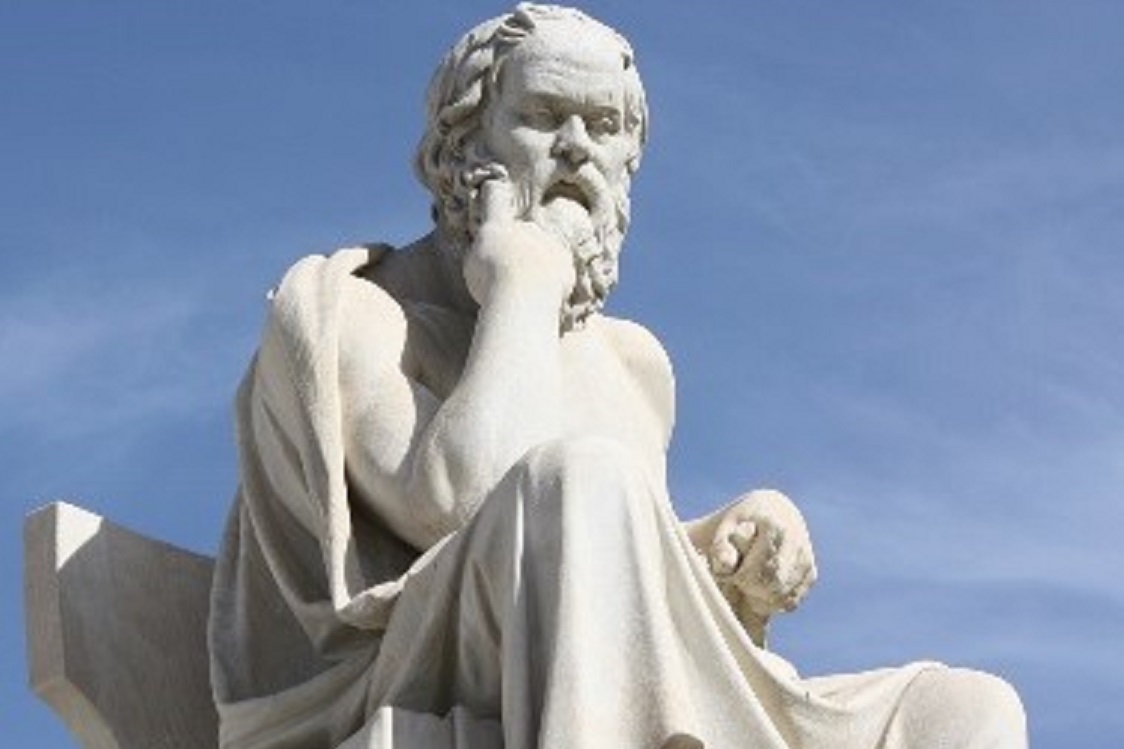È evidente che, con una catastrofe sismologico-umanitaria in atto appena al di là del mare, discettare sulle prodezze di un conterraneo millennial che, LEGGERMENTE imbaldanzito (leggasi: gonfipallonito) dai più recenti (effimeri? traslucidi?) successi discografici, si è messo a sfasciare il palco del Sacro Festivàl di Sanremo (le Dionisie italiche, if you know what I mean…), potrebbe risultare fuori luogo. Anzi, lo è di sicuro. Poiché però di mestiere non faccio il sismologo né ho competenze in materia di protezione civile, ma mi occupo di ammannire contenuti formativi, preferisco parlare di ciò che so. E so che lo spettacolo blanchesco di ieri sera non è stato triste solo per la cosa in sé (potremmo citare perlomeno il ricco precedente dei Placebo nel 2001 o la goffa galanteria di Al Bano nel 1999 che estirpò mezza aiuola dalla scenografia per porgere un fiore alla presentatrice), ma per i messaggi che esso veicola.
Ora, il nostro [Riccardo Fabbriconi, in arte] Blanco, a fronte del problemino con gli auricolari, non ha, come qualsiasi persona matura (ha già 20 anni, remember) chiesto di interrompere l’esibizione, aggiustare il guasto e riprendere. No. È andato avanti a distruggere il distruggibile con la risibile motivazione che “non funzionava niente, non si poteva fermare [?] comunque mi sono divertito”. Che il nostro Blanco non sia un mago della subordinazione era chiaro già dall’anno scorso, quando le sue risposte nelle interviste non superavano la reggente, una coordinata per asindeto, una risata, un’espressione gergale (“siamo saliti sul palco abbiamo fatto i felicioni”) e ciao. Ma del resto, si diceva, il suo mestiere è cantare [accusa di spocchia da laureato in Lettere in arrivo tra 3...2...1...]. Certo. Poi è chiaro che una capacità di articolare il pensiero dovrebbe essere spia di un’altrettanta capacità di articolare i comportamenti. E, sapendo che nel periodo esistono una reggente e le sue subordinate, si dovrebbe di conseguenza capire che in una situazione formalizzata come il Sacro Festivàl non si può fare quel che si vuole, ma esistono delle regole (certo, anche Catilina subordinava benissimo, almeno a leggere i resoconti sallustiani, e per poco non rovesciava il governo di Roma, ma insomma).
Se poi ieri sera la sua scarsità espressiva non ha mancato di manifestarsi con quel “mi dispiace A tutti” ansimato a microfono in gola, la vera scarsità da intorcinare le ime budella è stata senza dubbio quella gestionale di [Amedeo Sebastiani, in arte] Amadeus. Il quale, con la stessa espressione da “scusate, non so fingere che sia tutto combinato” già impiegata nell’indimenticato (pseudo-) alterco Bugo-Morgan di tre anni fa, non fa quello che ogni adulto normosenziente avrebbe fatto, cioè afferrare Blanco per un orecchio, trascinarlo giù dal palco, portarlo gentilmente fuori dall’Ariston, caricarlo su un Boeing di sola andata per Albenga urlandogli di non tornare mai più, risalire sul palco, scusarsi col mondo intiero e offrire il capo alla (metaforica) ghigliottina di giornali, Moige e social assortiti sperando in una (prevedibile) assoluzione (“eri in buona fede, dai”). Macché: come certi genitori schiavi dei capricci dei figli, anzitutto zittisce a più riprese la platea inferocita (perché ovviamente il problema non è Blanco che l’ha combinata, ma il pubblico che se l’è presa), si rivolge con l’occhio umido a Blanco, gli chiede di spiegarsi, Blanco non fa altro che aggravare la sua posizione a colpi di frasi giustapposte una più imbarazzante dell’altra e poi arriva subliminalmente la proposta di andare a rilassarsi un attimo in camerino, “perché la canzone di Salmo bisogna sentirla, poi, se vorrai, DOPO LA RICANTI”.
Certo. Poi si passa, come si trattasse con un bambino cinquenne, a fare l’esegesi dei fischi del pubblico, perché il ventenne Blanco (20 anni = diritto di voto = maturità) evidentemente non ci arriva da solo: “Fischiano perché [anzi x’] non capiscono perché l’hai fatto”. E Blanco cosa risponde? “No, li dovevo spaccare comunque” e Amadeus subito a fargli eco asilo- style guardando in galleria: “Li doveva spaccare comunque... perché, qual è il significato?”. Qui Blanco poteva fare il Luigi Tenco 4.0, millantare crisi esistenziali che manco Jean-Michel Basquiat, oppure denunciare i mali del mondo, chiamare l’Occidente a raccolta contro la farina di grilli, qualsiasi cosa E INVECE: “Il significato è che non andava la voce, allora mi son detto mi diverto comunque [??]… tanto la musica è la musica [???]….” più altri ragionamenti ugualmente incomprensibili. La folla folleggia e Amadeus, in luogo di prendere Blanco per un orecchio, trasformarsi in Rubber di One Piece e con una sola torsione del braccio scaraventarlo direttamente a Calvagese, scendere dal palco e farsi sostituire nella conduzione da Dodò de L’Albero Azzurro, che fa? Esige il silenzio dal pubblico, “magari non è stato bello quello che avete visto e lo comprendo PERÒ siccome non ha funzionato niente se vuoi torni dopo”. E Blanco: “Sì, dai, mi piace la musica”. Del resto, chiosa Amadeus, povero cocco, era agitato e “gli è partita la sciabbarabba”. No, caro [Amedeo Sebastiani, in arte] Amadeus: prima che arrivino i soliti benaltristi a insabbiare il tutto con frasi tipo: “vi scandalizzate per Blanco quando c’è di peggio in giro”, diciamo subito CHIARO E NETTO che di [Riccardo Fabbriconi, in arte] Blanco parliamo QUI E ORA e, consci di tutte le tragedie dell’umanità in corso, esprimiamo il nostro assoluto disgusto per la scenetta da bambino viziato andata in onda ieri e soprattutto di come TU, assecondando l’andazzo che “i giovani vanno capiti, se li sgridi si traumatizzano” che sta letteralmente distruggendo la nostra società a partire dalla scuola, hai minimizzato il tutto, forse anche con un occhio all’Auditel, agli sponsor, ai diritti d’autore di Salmo, boh. Sarà la (super)star da tenere buona a tutti i costi, ma di fronte a comportamenti incivili come il suo non esistono attenuanti, altrimenti il messaggio che passa ai giovani impressionabili è: “Visto che figo? Ha spaccato tutto e lo hanno anche invitato a ricantare”. L’idea cioè che se fai un po’ di caos tutto ti è perdonato perché, poverino, bisogna capirti, che a 20 anni “sei ancora un ragazzo”, che in fin dei conti “non hai fatto niente di grave”, che tutto ti è dovuto. Poi – sempre POI- ci si straccia le vesti quando si assiste ad atti di vandalismo assortiti, violenze di ogni tipo su cose & persone, si organizzano pensose trasmissioni “su dove stiamo portando i nostri giovani” e “chissà come mai siamo arrivati a questo punto” quando la risposta è già lì. Ma ovviamente è sempre colpa degli altri.
Raramente abbiamo visto una simile prova di inciviltà giustificata, ma se c’è qualcosa che ancor più ci indigna è il comportamento dei giornali che riportano la notizia della Blancheide come fosse un dettaglio di colore. Un unico articolo di condanna su Repubblica online è sparito dopo che Blanco ha pubblicato il rap di scuse su Instagram; per il resto, il nulla. Fosse accaduto nei Festivàl condotti da [Giuseppe Raimondo Vittorio, in arte Pippo] Baudo, minimo ci sarebbero state edizioni straordinarie con titoli a scatola [ORRORE ALL’ARISTON] e richieste di ergastolo ostativo: tanto per dire, il presunto aspirante suicida di Sanremo 1995 fu subito oggetto di sarcasmo da parte dei giornali che pensarono immediatamente alla montatura. Qui no, del Festivàl ormai si parla sempre e solo bene, perché parlarne male non fa vendere le già poche copie che i giornali riescono a piazzare. Altri tempi quando titoli come: “Sanremo, va in onda la noia” erano pronti già un mese prima, adesso un Festivàl che dal 2010 non si schioda dai 10-11 milioni di spettatori a sera, che ai tempi di [Giuseppe Raimondo Vittorio, in arte Pippo] Baudo sarebbe stato un ascolto fallimentare – e Sanremo 1995 non scese mai sotto i 15 milioni medi a sera - è sempre celebrato come un trionfo perché invece dei numeri assoluti si è deciso di considerare lo share. Il che non è certo un male, ma serve a coprire l’emorragia di ascolti rispetto ai tempi d’oro. Ma chi ne parla più? Ogni serata è un colpo di genio, sempre meglio dell’anno prima, e i giornalisti snobboni – gli stessi di oggi– che crocifiggevano [Giuseppe Raimondo Vittorio, in arte Pippo] Baudo perché a Sanremo 1995 era finita ultima Patty Pravo con Giorgia vincitrice, giornalisti che si vantano di aver dato del tu a De André e di scambiarsi messaggi di buon Natale con De Gregori e Fossati, oggi si spellano le mani ad applaudire i Coma_Cose, Madame [anch’essa perdonata a furor di Spotify, “in fin dei conti cos’è un Green pass falsificato…?”] e Tananai. Certo certo. Tengo famiglia. E Blanco in fin dei conti è un ragazzo.
[ultima nota ai benaltristi: prima di sentirmi chiedere – dopo tanto pontificare- se anche noi della scuola non abbiamo da fare autocritica, la risposta è ovviamente sì, ma le cause remote di questi disastri – rassegnatevi – stanno altrove]